

Ora sì che sarai più furioso che mai, buon vecchio Amleto! Un grande ritorno e altro da non perdere a fine novembre
24.11.2025

Prima del suo memorabile discorso politico, Ursina Lardi per due sere si è spesa meravigliosamente sul palco del Teatro delle Tese in Arsenale, perlopiù alla sua maniera così naturale e understatement, nel nuovo ‘Die Seherin’, ‘The Seer’ o La Veggente che dir si voglia. Eppure alla fine s’è detto, persino tra gli appassionati a oltranza del teatro post-brechtiano di Rau, che forse in questo ‘Die Seherin’ non funzionava proprio tutto a dovere.
Con questo psuedo-Filottete a Mosul, giocato sul confronto tra una ex fotografa di guerra e una vittima della ferocia islamista, in effetti non si è ripetuta la magia che alla Biennale dello scorso anno aveva stregato gli spettatori per ‘Medea’s Children’, l’ultimo lavoro dello stesso Milo Rau per NtGent (una sorta di ritorno al primo spettacolo rivelazione, ‘Five easy pieces’, sempre con bambini alle prese con fatti di cronaca crudeli del nostro mondo).
Per questa nuova Veggente prodotta con Schaubühne-Berlin, c’è stato a Venezia anche un considerevole inciampo tecnico a rovinare il finale della prima replica, che pure in alcuni momenti aveva colpito il folto pubblico presente, per esempio durante il passaggio in cui la fotografa rivive i momenti più caldi della propria carriera, gli scatti più drammatici, le situazioni limite.
Lo sforzo notevolissimo e lodevolissimo dell’interprete ha fatto centro, anche se proprio nelle scene forti della fotoreporter in overdose da adrenalina Ursina Lardi ha dovuto giocoforza andare sopra le righe. E l’appassionato più adorante della sotto-recitazione magistrale che sa mostrare abitualmente, anche nello stesso ‘Die Seherin’, nota bene la differenza.
In ogni caso Milo Rau sta alle ultime Biennali quasi come il mitico Max Reinhardt alle prime d’epoca fascista, ché dovette arrivare un diktat di regime da Roma per imporre lo stop alla partecipazione del grandissimo uomo di teatro d’origine ebraica.
Gli ultimi curatori Stefano Ricci e Gianni Forte, o ricci/forte che furono, avevano puntato tantissimo sull’asse con il regista-guru d’origine svizzera, e l’attore americano ha voluto rinnovare la scommessa.
Ma il risultato effettivo è stato solo in parte eclatante: persino il discorso del regista-guru al Talk non è stato memorabile o particolarmente brillante, a parte piccoli passaggi di memorie personali, certo niente a che spartire con la strepitosa cerimonia del Leone d’Argento e l’intervista seguente della Lardi. Oltre all’effetto Ursina, l’asse con Rau ha portato a Venezia un nuovo interessante assaggio con Princess Isatu Hassan Bangura, peraltro già calata dalla scuderia di NtGent al Roma Europa Festival nel 2023.
Bisogna anche considerare che parliamo di un personaggio come Rau, iper-attivo e impegnatissimo tra il rilancio di Wiener Festwochen, le code varie del mega-progetto ‘Histoire(s) du théâtre’ con NtGent e le attività propriamente politiche come la campagna Resistance Now! e altro ancora della sua casa di produzione IIPM – International Institute of Political Murder.
Nel frattempo, informava puntualmente Cristina Piccino su ‘il manifesto’, Rau ‘ha lavorato ad altre tre regie: ‘The Pelicot Trial’, sul caso di Giselle Pelicot venduta dal marito agli uomini della cittadina francese che la stupravano collettivamente nel sonno – la drammaturgia è di Servane Dècle, sarà presentato al prossimo Festival d’Avignon; ‘Congress of Vienna’ in cui affronta il tema della cancel-culture; e ‘Burgtheater’, il testo di Elfride Jelinek (premio Nobel per la letteratura) mai più rappresentato dal 1985, dopo che la prima a Vienna provocò reazioni molto violente contro l’autrice, dato che nella parabola del più importante teatro nazionale illumina quelle zone oscure della storia austriaca, che riguardano i legami col nazismo capovolgendo la narrazione dominante di un paese ‘vittima’ in quella di un paese complice’.
Alla fine quel che conta davvero per Rau lo si è visto anche dal look auto-promozionale sfoggiato a Venezia, una tuta da operaio con il logo di ‘Republic of Love’, titolo dell’edizione di quest’anno di Wiener Festwochen. Cioè abbia a cuore soprattutto il suo mega-festival, è abbastanza naturale: si tratta pur sempre di 38 giorni di rappresentazioni per oltre centomila spettatori (93 per cento l’indice d’occupazione dei posti disponibili, ovvero quasi il tutto esaurito), una ricaduta in streaming di 730mila visualizzazioni e più di duemila articoli di giornale con 245 cronisti accreditati da 26 Paesi diversi.
Per la soddisfazione di Rau, che adora googlare il suo nome ogni mattina sul tablet con cui fa colazione, quest’anno Wiener Festwochen è stata definito addirittura ‘la quinta stagione di Vienna’ (Taz) e ‘il Santo Graal del teatro contemporaneo e il luogo di ogni polemica’ (RTS svizzera).
Lo stesso ‘Die Seherin’, ben diversamente che nella sfortunata prima replica a Venezia, al debutto nel festival viennese ha vissuto quasi un trionfo. E il motivo è presto spiegato. Come da copione, il finale con la riflessione interiore ad alta voce della Veggente protagonista - che torna indietro, a prima dell’inizio, mettendo a fuoco il tema della casualità dell’incontro con lo sconosciuto interlocutore -, s’interrompeva bruscamente. Ursina Lardi rompeva del tutto la quarta parete avvertendo: ‘Gentile pubblico, a causa di un'emergenza dobbiamo interrompere lo spettacolo. Il personale vi terrà informati sugli sviluppi. Grazie per la vostra pazienza!’.
E, dopo un’opportuna pausa, tornava in scena da dietro il grande schermo sbucando insieme con il co-protagonista Azad Hassan, fatto venire apposta dall’Iraq, con un commovente e applauditissimo passaggio dal virtuale al reale, che a Venezia è invece mancato.
Non a caso, nella bella mezz’oretta di chiacchiere seguite al Leone d’Argento, con la brillante moderatrice ‘embedded’ di Biennale, la professoressa e critica Maddalena Giovannelli, Ursina Lardi stessa, esprimendo con sincerità le sue idee sul teatro, ha manifestato persino una certa perplessità nei confronti dell’uso in scena di proiettori e di immagini video registrate, ovvero di uno degli strumenti chiave del suo regista di riferimento Milo Rau.
Ovviamente Ursina ha premesso che ci sono circostanze che rendono necessario il ricorso ai filmati, come nel caso dello spettacolo ‘La Veggente’, dato che il co-protagonista da remoto non può certo partecipare dal vivo a tutte le rappresentazioni...
Questo per quanto riguarda ‘Die Seherin’, che certo non è stato lo spettacolo che ha fatto più rumore delle nuove produzioni di Rau, scavalcato alla grande, per la crudezza e per l’attualità, da ‘The Pelicot Trial’, la cui prima viennese - vanta un comunicato dell’ufficio stampa di Wiener Festwochen - ‘ha catalizzato l’attenzione di un centinaio di reportage in tutto il mondo. L’agenzia France Presse e il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ sono rimasti affascinati dall’oratorio di oltre sette ore, il ‘New York Times’ ha parlato di una serata piena di ‘intuizione e disperazione’ e il giornale tedesco ‘Die Welt’ l’ha definita ‘la cosa più scioccante che il teatro possa mostrare’. Sic.

Aldilà della vicenda Rau, che cosa si può dire alla fine della prima Biennale che Willem Dafoe ha voluto intitolare ‘Theatre is Body, Body is Poetry’? Tutto sommato ha messo insieme una buona rassegna, di cui sono state ufficialmente sottolineate l’affluenza di pubblico, 13 mila presenze, e l’eco mediatica internazionale, dagli Stati Uniti all’Europa. Nessuno ha chiosato troppo sul Leone d’Oro all’ex moglie, Elizabeth LeCompte, salvo che poi lo spettacolo connesso, ’Symphony of Rats’, ha subito numerose stroncature.
Sul consenso in Italia non potevano esserci dubbi, dati i nomi in ballo di autentici e riveriti Maestri (da Eugenio Barba a Romeo Castellucci, da Rau a Thomas Ostermeir e al grotowskiano Thomas Richards), e considerando pure che questa Biennale, soprattutto nelle appendici formative e nelle iniziative collaterali, non si è sottratta alla trita logica del ‘teatralismo relazionale all’italiana’. Peraltro, questo ha dato anche ottimi frutti, per esempio con la scelta di far riprendere da Antonio Latella i saggi di fine anno con gli allievi dell’Accademia Silvio d’Amico.
Di materia per riflettere sul solito giro da cui un ‘estraneo’ di grande fama come Dafoe poteva pur sempre stare alla larga e per valutare l’ambivalenza dei Grandi Nomi, il cur-attore volendo potrebbe trovarne pure nel caso di Romeo Castellucci, l’altro asset di rilievo nel bilancio del Teatro 2025.
Sul nuovo lavoro del padre nobile del Post-Drammatico, ‘I mangiatori di patate’, una produzione di rilievo anche solo per la location allestita nell’Isola del Lazzaretto Vecchio, come al solito si può dire tutto e il contrario di tutto, che è esattamente l’effetto di ‘dis-interpretazione’ voluto dal Maestro cesenate soprattutto nelle cosiddette installazioni.
Abbondavano i riferimenti artistico-monumentali, dal Van Gogh del titolo che ritrae un misero pasto dei diseredati - raddoppiato dalla presenza di performer vestiti da minatori del Borinage, sempre del primo periodo belga da evangelizzatore del giovane Vincent -, all’Angelo della Storia da Paul Klee di Walter Benjamin, con l’impetuoso vento del Progresso alle spalle.
Volendo si poteva trovare persino qualche remota citazione nell’impiego dei sacchi neri della spazzatura e di altri materiali poveri, forse un eco della stagione delle plastiche di Alberto Burri, piuttosto che di Joseph Beuys. Qualcuno ha anche parlato di un conradiano ‘inoltrarsi di un piccolo gruppo di spettatori verso un cuore di tenebra’, a proposito dell’esperienza di fruizione quasi al buio. Eccetera, eccetera, eccetera: fa impressione anche solo la quantità di rimandi che un critico specializzato come Simone Azzoni ha potuto citare su ‘Art Tribune’ (1).
Al netto di una sorta di momentanea resurrezione del corpo nudo-nudo di una performer, non è che si sia poi visto questo gran miracolo di San Romeo. Astenendosi dai giudizi di merito, perché parliamo pur sempre di un livello notevolissimo e di un’opera così grandemente allusiva, certamente si può dire che anche in Castellucci, come nel caso di ‘Die Seherin’ di Rau, si nota ormai un certo auto-compiacimento.
Rau che apertamente cita se stesso e il suo repertorio, celiandosi ma non troppo, lascia il dubbio che alla fine vorrebbe essere sempre lui la fotoreporter intorno a cui costruisce la storia. Castellucci forse punta direttamente all’assunzione nel cielo degli Artisti, obiettivo non proprio taciuto nel logo stesso della sua Societas Raffaello Sanzio. Viene il dubbio che, in fondo, il teatro borghese in cui sono venerati come numeri uno, stia tanto stretto a entrambi.
Tornando a Venezia 2025, parliamo pur sempre di una rassegna che si era data come tema forte ‘Biennale 1975-2025: cinquant’anni di nuovo teatro’. Titolo aulico che, per quanto fattivamente sostenuto dall’intellettuale organico di casa Andrea Porcheddu, assurto al rango di co-curatore di Dafoe, si è smontato subito da solo, soprattutto per quanto riguarda l’attualità della ‘lezione’ di quei personaggi riuniti da Luca Ronconi. Tra i pochi protagonisti ancora in campo di quella stagione, il primo a dire che il discorso non stava in piedi, è stato il fondatore di Odin Teatret Barba.
Che un’istituzione pubblica rivendichi il proprio ruolo storico è più che legittimo, ma l’auto-monumentalizzione fatalmente gioca brutti scherzi. E così di quel ‘nuovo’ buttato là assertivamente, come aggettivo unico, si è fatto terribilmente fatica a trovarne traccia.
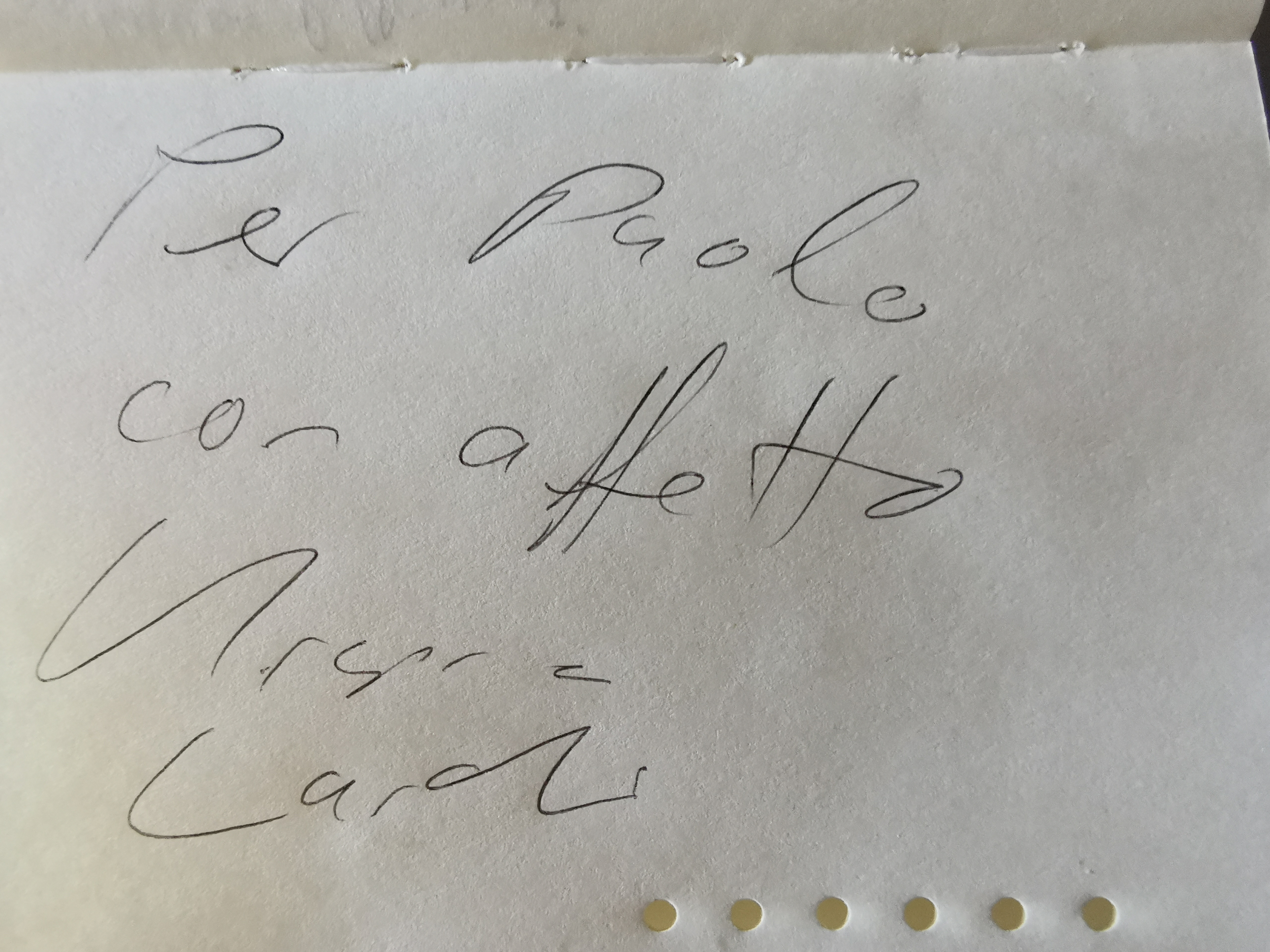
(1) Ecco il ‘Castellucci’s Artistic Quote Index’
(...) Immaginario e immaginazione questa volta in un nesso causale per Romeo Castellucci che incunea nella memoria latente (e malata) del Lazzaretto Vecchio i suoi Mangiatori di patate. Dispositivo scenico del vuoto che ingurgita e vomita la drammaturgia postmoderna di Piersandra Di Matteo (tanti anni fa responsabile della rubrica di teatro proprio su Artribune). Stationendrama orizzontale e scomposto. Tappe senza soluzione di continuità su cui si staglia l’Angelus Novus di Benjamin. Sotto di lui le ceneri confuse della storia, i residui del secolo come li aveva immaginati Joseph Beuys. Monoliti, bracci meccanici di un Frankenstein senza volontà creatrice. L’opera omonima di Van Gogh si perde come in un’installazione di Greenaway in cui i personaggi escono dalla storia e diventano drammi singoli di caduta e redenzione. Ci sono le reminiscenze ai piattelli labiali che storpiarono le voci come nel suo Giulio Cesare e poi le sonorità battenti di Scott Gibbons. Le immagini che si liquefano e si ri-coagulano dentro frammenti di engrammi iconografici: deposizioni, tagli laterali alla Rembrandt, il Richard Serra alchimista di Matthew Barney, realismi courbetiani: un unico flusso che scorre nei vuoti del Lazzaretto senza resurrezione, senza soluzione di continuità. (...)