

Ma è poi bello o brutto, questo benedetto 'Riccardo III' che rilancia il Piccolo come teatro d'arte per Tutti?
17.11.2025

Viene naturale discutere a fondo del teatro di Milo Rau, e puntualmente capita ogni volta dopo i suoi spettacoli. Figurarsi nel caso di questo nuovo ‘Medea’s Children’, presentato al pubblico italiano nel gran finale di Biennale Teatro 2024, sabato 29 e domenica 30 giugno.
Del resto, l’attesa degli appassionati era grande, persino a prescindere dal contenuto più o meno ‘scandaloso’. Ed era legata al fatto che con questo spettacolo uno dei protagonisti più di peso della scena culturale europea, qual è Rau, chiude il suo settennato da direttore del teatro nazionale belga NTGent e conclude pure la sua importante trilogia di riletture dei classici, che ha visto le rappresentazioni prima di ‘Oreste a Mosul’ e poi di ‘Antigone in Amazzonia’.
Prima ancora di accapigliarsi su quanto Rau abbia effettivamente spinto la macchina evocativa del mito teatrale greco che di per sé appare il più crudele, sull’eventuale ambiguità dell’impiego di minori in scena e via elencando, insomma sul contenuto specifico di questo ‘Medea’s Children’, c’è dunque da considerare proprio l’aspetto storico-biografico relativo al delicato momento di passaggio dell’autore guru.
In effetti, persino nelle inevitabili imperfezioni - un addetto ai lavori italiano faceva subito notare agli amici un certo quale scollamento tra le parti relative alla tragedia classica e le incursioni sul presente - lo spettacolo segna davvero il giro di boa di un periodo.
Da un lato vi è una sottrazione (apparente) dell’afflato militante e politico del teatro neo-brechtiano di Rau, rispetto per esempio all’ultima Antigone.
D’altro canto si comprende quanto la presenza di ragazzini, con la freschezza e l’ironia che portano in scena, aiuti a non far pesare quella che può apparire come una certa stanchezza di linguaggio, nel suo teatro stilisticamente così connotato, insieme multimediale e didascalico.
Vista ‘Medea’ si presume che alle prossime mosse Rau tenterà di spiccare un altro salto in avanti, nella nuova veste di curatore - con puntuale nuovo Manifesto programmatico anche stavolta - delle Wiener Festwochen, trasformate subito in Libera Repubblica di Vienna, e in chissà cos’altro.
Ha ben raggiunto ormai la maturità, e anche il successo, e soprattutto un’elevata soglia di esperienza come autore, regista e direttore, fatta di una cinquantina di spettacoli in proprio e di tanti altri come maieuta, che lo portano appunto inevitabilmente a ricoprire ancor più il ruolo di punto di riferimento.
In che direzione potrà andare una nuova fase, non è facile prevederlo. Potrebbe persino uscire dall’attività di creatore e regista teatrale: paradossalmente per lui il palcoscenico non conta più di tanto, come spiegò due anni fa in una bella intervista al giornalista svizzero-berlinese Tobi Müller. ‘La scelta del mezzo espressivo e dell’arte non è così importante’, Rau dixit, quanto invece l’impostazione rivoluzionaria, da attivista in servizio permanente effettivo.
In effetti lo stesso Rau, classe 1977, svizzero di San Gallo, dopo aver studiato sociologia e letteratura a Parigi, ha cominciato a impegnarsi nello spettacolo con un progetto cinematografico sui movimenti rivoluzionari in Chiapas, per cui si è dovuto persino indebitare. Fino a che un giorno, a Berlino, si è imbattuto per caso in un gruppo di studenti e studentesse di recitazione e così presto si è ritrovato a fare il regista.
Come valutare allora, tornando a questo Medea, la scelta di affidare alla più piccola e candida delle protagoniste (dovrebbe trattarsi di Bernice Van Walleghem, secondo il tamburino fornito alla Biennale di Venezia) l’evocazione ammirata e ripetuta di Samuel Beckett e di ‘Aspettando Godot’? Nel primo dialogo sul teatro Rau le fa buttare lì addirittura l’affermazione: ‘Penso che meglio di Eschilo ci sia solo Beckett’, nel senso di andare dritti ai fondamentali, ‘La legge divina. L’assurdità dell’esistenza’.
E’ peraltro arcinoto che il grande Sam aveva una tale allergia alle interpretazioni attualizzanti del suo teatro che riuscì a litigare persino con un personaggio come Adorno, a proposito di una lettura politica di ‘Finale di partita’ avanzata dal fondatore della Scuola di Francoforte.
Suona pur strano anche quando Rau mette in bocca all’altro piccolino dei suoi giovanissimi attori, il più saputello (uno strepitoso Elias Maes), pur fanatico di Euripide in quanto padre remoto del dramma psicologico, il raccontino che segue.
‘Posso dire che la prima di ‘Medea’ fu un disastro totale? Perché infuriava ‘la guerra tra Atene e Sparta, che segnerà la fine di Atene e tutti stavano cercando di salvare Atene’, ma Euripide ‘viveva recluso in una grotta’ dove scriveva con la testa così distratta dalla realtà che finì ‘divorato da un branco di cani selvaggi’.
Poi, questo precocissimo critico e storico delle scene arriva al dunque: ‘Per me Medea è una storia di abbandono, di solitudine’.
S’aggiunga la chiosa - di Elias o di Bernice o di un altro fa lo stesso: ‘Sì, a questo punto è chiaro. Voglio dire che il teatro nasce dallo spirito della musica. All’inizio, il teatro era tutto cantato, erano tutti cori. E quando il primo attore è uscito dal coro per recitare un monologo, è iniziata la fine del teatro. E la solitudine della condizione umana’.
Attenzione, Rau così non manifesta una sorta di abiura all’art-attivismo dichiarato, anzi: anche a Vienna l'ha messa subito in politica, il suo IIPM – International Institute of Political Murder - ha più di quindici anni ma è più vivo che mai. Insomma, non è il nuovo Brecht che lascia posto a un impossibile novello Beckett.
E non è nemmeno in parte, questa 'Medea's Children', l’autocoscienza di un maestro che si sente un po’ vecchio, e che forse era proprio un terribile immoralista, sospetto che aleggia in scena a proposito del primo istruttore dei ragazzi, Dirk, che alla fine viene salutato con un bel: ‘Non credo tornerà mai. Come Godot’, proprio prima che calino buio e sipario.
Aldilà di ogni suggestione del genere, bisogna tener presente che Rau, con la sua poetica di messa a nudo della rappresentazione, ha anche una magia tutta particolare nel gioco degli spiazzamenti. Tant’è che gli incipit dei suoi lavori più riusciti sono sempre strepitose deviazioni.
Questa volta c’è la chiacchierata informale e giocosa, con tante frasi pronunciate in un goffo italiano, giù dal palco con gli appunti in mano, che sarebbe la presentazione del (falso) talk post-spettacolo che dovrebbe seguire.
Il bravissimo Peter Seynaeve, l’attore-guida dei ‘Medea’s Children’, si fa trovare in sala mentre ancora entra il pubblico, s’aggira un po’ imbarazzato e inquieto, tormentando le narici e il foglietto che stringe, come per caricarsi.
In sostanza, Rau sembra indicare da subito che ricorrerà ai giovanissimi prima di tutto per presentare una riflessione sul teatro, sincera, diretta, senza filtri, non del genere di quelle degli adulti o peggio ancora degli esperti e dei giornalisti, che non fanno - e non si pongono - ‘vere domande’, perché ‘vogliono solo mostrare quanto ne sanno’.
Ma è soltanto un pretesto narrativo, anzi uno sfondo, proprio come laggiù sullo schermo luminoso la riproposizione quasi da graphic-novel della Medea originale.
In realtà lo spettacolo rievoca e analizza un fatto epocale della cronaca nera belga, l’infanticidio atroce, attraverso lo sgozzamento, dei cinque figli da parte di una madre che ha poi chiesto e ottenuto l’eutanasia in carcere.
Piccolo passo dietro le quinte: la firma che compare in tamburino subito dopo quella del creatore e regista, è quella della drammaturga Kaatje De Geest, che è anche una studiosa di teatro e di letteratura soprattutto di area scandinava, a proprio agio tra Strindberg e Ibsen.
Prima di entrare nella squadra dell’NTGent, dove ha fatto anche l’assistente del direttore, Kaatje aveva pubblicato con lo stesso e Carmen Hornbostel - altra drammaturga e collaboratrice di Rau nella società di produzione IIPM - il volume di saggi ‘Perché il teatro?’, tradotto in italiano da Cue Press.
Dal suo testo originale, che è stato scritto in ducht flemish, ovvero nell'olandese cosiddetto del sud, è stata ricavata una prima traduzione in inglese, commissionata dalla produzione a Helen White, traduttrice già impiegata più volte dallo stesso Rau, e da questa discende, in terza battuta, la versione di Martina Vigna in italiano, adattata per i sovratitoli, per Biennale Teatro.
E se le inevitabili improvvisazioni e/o imprecisioni di un cast di giovanissimi possono essersi perdute dal vivo, così da rendere magari approssimative alcune osservazioni del dopo, non può valere lo stesso per i monologhi chiave che vengono riproposti come tali, con tanto di enunciato retorico introduttivo.
Sicuramente il più significativo, perché si propone di esporre il punto di vista finale della pseudo-Medea contemporanea belga, è l’ultimo. L’attrice ragazzina chiamata al compito più ingrato, Helena van de Casteele (gli altri attori, oltre ai due più piccoli già citati, erano Aiko Benaouisse, Ellan Brennan e Juliette Debackere, tutti capaci di catalizzare l’attenzione, bravi da dieci e lode), termina la lunga scena horror in cui perpetra il pluriomicidio, ripresa dal vivo da Peter, il narratore adulto, che in qualche modo collabora soprattutto all’accatastamento dei cadaveri sanguinanti.
Helena si riprende a fatica dallo sconquasso emotivo, si dichiara anche lei infelice nella vita vera, perché bullizzata a scuola per l’aspetto fisico, ma vuole lo stesso recitare il monologo dell’eutanasia attribuito alla povera assassina.
Questo testo (1) si apre con un shakespeariano ’L’umanità non è che il sogno di un’ombra’ e si chiude con un prosaico e nichilista ‘la vita non è che un cubetto di ghiaccio gettato nel mare, diceva mia nonna…’, scavando a fondo in una proverbiale disperata solitudine della condizione umana di oggi. ‘Qualcuno avrebbe potuto aiutarmi’, ammette con coscienza la donna, ‘l’amore avrebbe potuto salvarmi’.
Nulla, nemmeno la parabola inquietante della vita di questa donna, in fondo riesce a far breccia davvero nel cuore arido di un’Europa dove il vuoto antropologico del post-capitalismo ha annacquato anche i tabù fondativi della civiltà cristiana, vanifica l’opportunità sociale dello scandalo, impedisce persino che i miti del teatro greco esprimano ancora la forza archetipica.
Questa storia vera di una neo-Medea che sembra una Madonna al rovescio, Rau senza moralismi la sottopone al racconto e al giudizio delle voci profetiche dei bambini, mettendo a nudo prima di tutto la nostra ipocrisia.
Altro che disimpegno, ‘Medea’s Children’ è un manifesto che prende tutt’insieme gli snodi più oscuri del presente, nessuno escluso, dalla pedofilia alla violenza insensata, dall’animalismo estremo al suicidio assistito, per raccontarci in quale società stiamo sprofondando, che non solo è ‘liquida’ nel senso indicato dall’intuizione sociologica di Zygmunt Bauman, ma si è proprio ormai sciolta nel mare del nulla.
Tornato ad affrontare di nuovo la realtà più vicina, come nel capolavoro ‘La Reprise’ e in altri lavori precedenti, Rau sembra sempre più un pessimista radicale, ma non è così: nella stessa presenza dei piccoli in scena, per una storia pur tanto incompatibile con ‘il teatro dei ragazzi’, c’è una scelta militante, pedagogica, coerente con il suo percorso d’artista.
Spiega perfettamente Peter ai ragazzini, in una sorta di controscena, a proposito dell’apoteosi nella Medea originale: ‘Ora tutto è odio. E la cosa più sacra di tutte, l’amore, sembra una maledizione’.
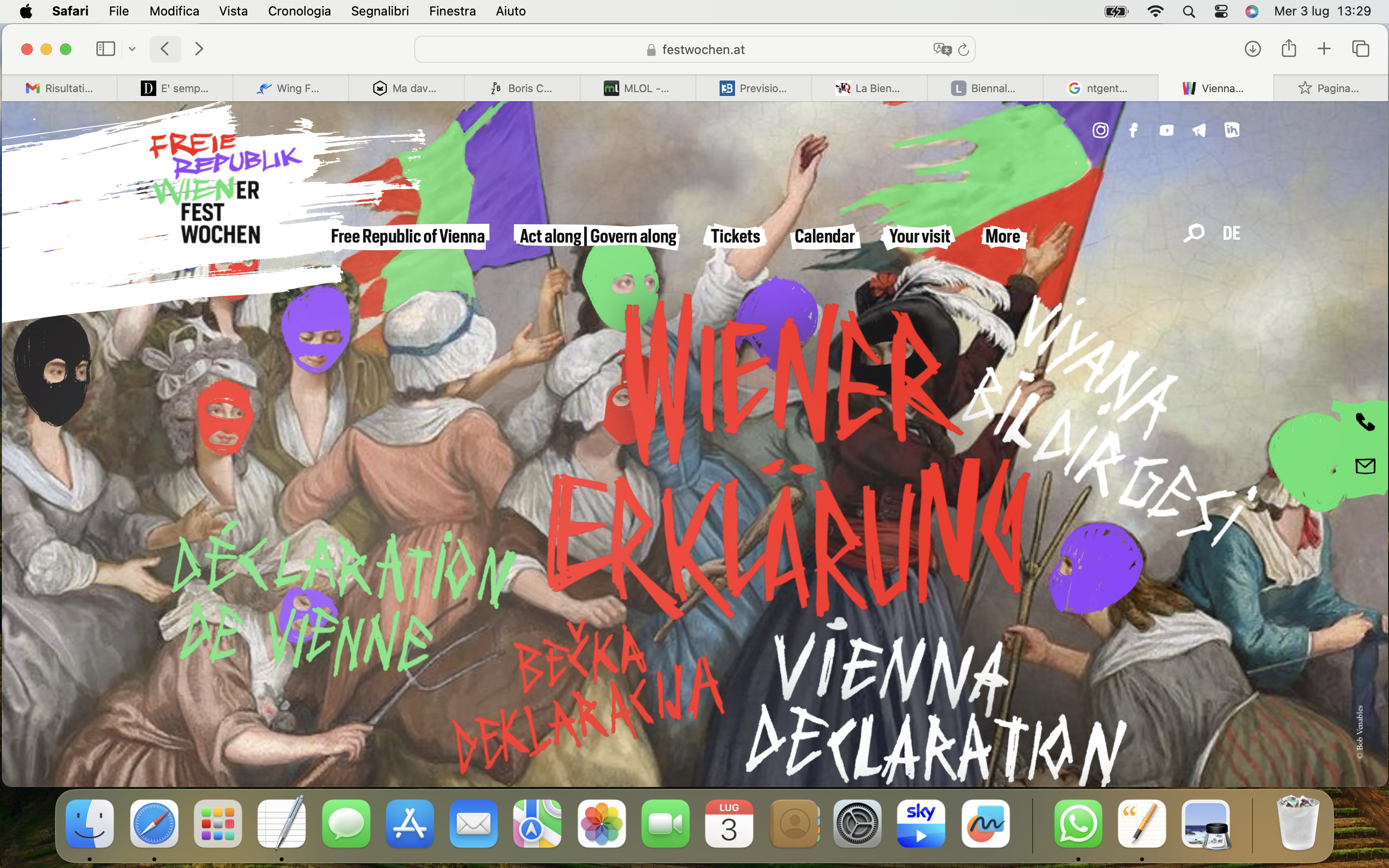
(1) Da ‘Medea’s Children’: il monologo finale
Qui qualcuno avrebbe potuto liberarmi
dalla mia solitudine.
Ma noi esseri umani siamo troppo deboli.
Troppo piccoli, troppo spaventati gli uni dagli altri.
Ma lo stesso io cerco nel pubblico
qualcuno che voglia salvarmi.
Qualcuno che voglia attraversare la vita con me.
Io ve lo dico:
Tutte le storie più belle
finiscono con la morte e l’orrore.
Cosa importa
se lo spettacolo è appena terminato
o se ancora dobbiamo imparare le battute?
Dopo l’amore c’è la separazione.
Dopo la vita c’è la morte.
Noi siamo i figli di noi stessi, le nostre stesse madri.
Soffriamo anche in punto di morte.
Ogni passo ci porta più a fondo nell’oscurità.
Andiamo più a fondo con ogni parola.
Come se ci fosse un accordo segreto
tra la generazione dei nostri avi e la nostra.
Noi siamo l’ultima generazione:
non attendiamo nulla.
Nulla deve ancora accadere.
Ma comunque siamo portati a ripetere i gesti dei nostri genitori.
Mia nonna ha detto:
“La vita è come un cubetto di ghiaccio gettato nel mare:
alla fine diventa mare anch’esso”