
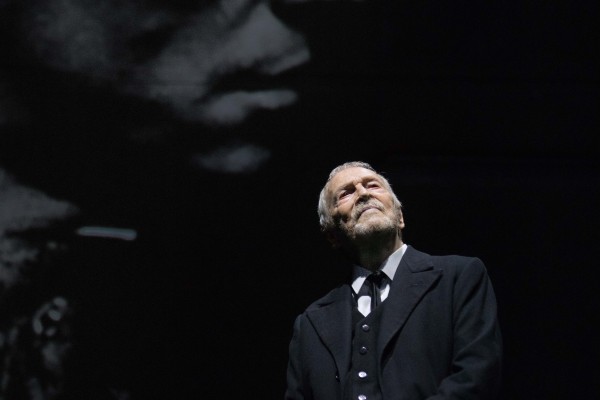
Semel in anno licet...studiare in tv la regia russa della Prima alla Scala e pure commuoversi per il grande Orsini
29.11.2025

Il palazzo della Triennale Milano è ormai quasi vuoto, sta facendo buio alle 19.30 di un bel solatio sabato di metà ottobre, anche fuori sullo scalone solitamente affollato non c’è quasi più nessuno.
Al termine della gradinata che dalla sala principale porta verso il teatro si trovano persino sbarrate le grandi porte tagliafuoco dell’ingresso.
Una signorina con la consueta t-shirt scura ‘Ask me’, indica la collega più in là nel corridoio, e sorridento gentilmente questa poi indirizza a un’altra giovane ancora in divisa ’Ask me’, che vidima elettronicamente i ticket.
Un po' alla alla chetichella quattro dozzine scarse di spettatori vengono fatti entrare così in una sorta di grande anticamera poco illuminata, da cui si accederà finalmente alla quasi del tutto buia e nera TDA room, dove solo un grande lenzuolo bianco appoggiato su un cassone da trasporto e lo schermo di proiezione già acceso riflettono un po’ di luce.
Forse ancora nessuno lo sa, ma fin dall’attesa ‘La vertigineuse histoire d’Orthosia’ si preannuncia come una discesa lontano, molto lontano, da quel certo Carnevale tragico del nostro presente.
A pochi passi lì di fronte c’è pure la grande apertura luminescente che introduce ai nuovi spazi stra-chic, d'un esagerato chiarore per esaltare i pezzi di design, cosiddetti della Cucina, l’ennesimo tempio della Milano della foodification per libagioni al dio marketing.
Tra l’altro, maledizione!, ora ogni volta che si va a teatro tocca di ascoltare nell’annuncio pre-registrato standard che segna l’inizio dello spettacolo, l’invito al pubblico di ‘proseguire nell’esperienza’ in questi quattro bar ristoranti.
Tornando al punto, attenzione: non si rivelerà una semplice 'stanza' il palcoscenico al rovescio, con una piccola platea di sedute, che così riconfigurato porta ancora l’acronimo stesso del Teatro Dell’Arte (TDA) davanti all'inglese ‘room’.
In realtà sta per assumere in pieno il significato etimologico di quel termine anglosassone inciso sul biglietto, ovvero la radice protoindoeuropea di 'room', che per i nostri remoti antenati dell’Urheimat indicava tout court uno spazio, inteso anche nel senso di apertura.
E per due sere in questo antro post-teatrale si è librata davvero come uno squarcio poetico e intellettuale di prim’ordine, la narrazione che gli artisti libanesi Joana Hadjithomas e Khalil Joreige hanno presentato.
E’ la storia di un’antica città romana, Orthosia appunto, che fu inghiottita da uno tsunami ed è riaffiorata per caso intatta dopo 1500 anni, sotto il campo profughi palestinese di Nahr el Bared, a due passi dalla Siria, dopo che l’esercito libanese aveva evacuato l’insediamento e lo aveva ridotto in macerie per stanare una banda di guerriglieri islamisti.
Vestigia del passato e della civiltà che fu, che l’inciviltà odierna dell’emergenza e della guerra ha fatto riseppellire in fretta e furia, tra lo sgomento degli archeologi accorsi all’uopo, perché andava ricostruito quanto prima il campo profughi.
Gaza è nominata una sola volta in 70 minuti, Israele nemmeno una, idem Hamas: eppure è certamente la performance più convincente e profonda a cui si possa assistere, in tempi di slogan urlati e di contrapposizioni radicali, sulla situazione di drammatica in Palestina e nel Medio Oriente, che è poi la crisi nella culla e radice della nostra stessa cultura e dunque possibilità di convivenza.
Certo non è un’opera di propaganda pro-Pal, assolutamente no: Joana e Khalil vogliono inserire il caso Orthosia esattamente in quella ‘vertigine della storia’ indicata fin dall’aggettivo nel titolo, in un tempo presente che è insieme consonante con ben determinate epoche del passato e anticipatore - si spera ancora, contro ogni logica pessimistica - di un futuro possibile, di fondazioni e rifondazioni di città e di civiltà che si sovrappongono.
I due artisti, che ormai sono di casa anche in Francia, mostrano una capacità di mettersi in gioco e di toccare con apparente leggerezza livelli intellettuali raffinati.
Si richiamano, nelle note a margine, alla lezione del sociologo Bruno Latour sulle trasformazioni del mondo, ma è facile sentir riecheggiare le Tesi sulla storia di Walter Benjamin: non il solito e abusato Angelo nella tempesta del progresso, dal dipinto di Paul Klee, quanto invece il concetto sottostante all’intera riflessione, della possibilità di un ‘tempo adesso’ che sia in qualche modo decisivo.

Ricominciamo un attimo dall’inizio. Già definire quale genere di appuntamento sia questo de ‘La vertigineuse histoire d’Orthosia’ è fare un torto a chi l’ha creato.
Non è uno spettacolo teatrale, anche se assume qualche stilema del cosiddetto teatro di narrazione nella versione contemporanea multimediale. Con la rinuncia programmatica, però, a quell’assertività retorica cui ci hanno abituato i nostri narratori teatrali di successo: persino nelle interviste registrate Hadjithomas e Joreige presentano le affermazioni degli interlocutori precedute con pochi stacchi di un tempo d’attesa, come se stessero ancora riflettendo.
Non è un film raccontato, anche se i due autori sono piuttosto conosciuti come filmaker e di una pellicola a tema vengono mostrati vari spezzoni e numerosi scatti di scena. Non è una conferenza o una lezione del genere che si direbbe brillante, come solo dei professori appassionati e adorabili sanno animare. Non è nemmeno un prodotto artistico, anche se una prima opera viene esibita nell'introduzione del racconto. E' un po’ tutto questo.
Gli stessi Joana e Khalil si presentano come autori di lavori di ricerca complessi che comprendono ‘una parte di performance che trasforma il progetto’. Come dicono nell’intervista tradotta per il programma di sala: ‘È un approccio legato anche al nostro interesse per la trasmissione dell’effimero, la necessità di una certa fragilità, l’abbandono delle forme di controllo e di potere. Si tratta di una posizione politica che cerca di sfuggire a definizioni e categorizzazioni’.
Ciò che alla fine colpisce perché è davvero ispirato e insieme insperato, è il tocco poetico e in qualche modo catartico con cui si chiude la rappresentazione vera e propria.
Ma non è finita - senza voler spoilerare troppo. Con un’altra magia, dopo aver coperto accuratamente anche il tavolo da cui hanno svolto il racconto con un lenzuolo bianco, proprio come è successo agli scavi di Orthosia, i narratori escono di scena mentre si solleva il grande schermo.
Si fanno ritrovare sorridenti in una sorta di secondo antro artistico-filosofale che il pubblico viene invitato a visitare con loro. Al centro, esposta come l’insolita sindone di una civiltà cadaverica, c’è ‘Under the Cold River Bed’, una scultura ricavata dall’impronta del campo di Nahr el Bared, con una sottile membrana che divide dimensioni temporali e territori diversi.
Dietro, è in mostra lo spettacolare palinsesto di immagini e disegni relativi a una grande raccolta di carotaggi del terreno di Beirut e del Libano, effettuati per le nuove edificazioni, immagazzinati e riconfezionati da Hadjithomas e Joreige come spunto iniziale di un grande lavoro che ha poi preso verie direzioni.
Joanna timidamente resta un po’ in disparte, chiacchiera fitto con alcuni che sono andati a cercarla, riceve complimenti e ringrazia, mentre Khalil si spende in giro, alternando francese e inglese, a spiegare ancora questa storia e questo lavoro, prima a un capannello e poi all’altro, come un mediatore museale modello: gli manca giusto la t-shirt ‘Ask me’…
Ancora seduto nella platea in penombra, li attende per un saluto, dopo che sono quasi tutti usciti, Maurizio Cattelan: poco o tanto che vi piacciano le provocazioni che lo hanno reso un arti-star, bisogna dire che è uno spettatore appassionato modello, non manca mai in Triennale quando c'è una proposta importante.
E' il primo che avrà sentito bene quanta passione e quanta intelligenza, quanta poesia e che tocco artistico s'effondessero da questa vertiginosa storia. E quali aperture in profondità Hadjithomas e Joreige lasciano poi nella mente di chi li vuole seguire.
E, quasi come una tautologia, spiegano così la loro poetica di scavi: ‘Il nostro ultimo lavoro, Unconformities, è incentrato su ciò che lasciamo dietro di noi, sui sedimenti del sottosuolo, sull’archeologia e la geologia. Il termine unconformity (“non conformità”) indica l’incontro forzato e inatteso tra due unità geologiche distinte in seguito a una catastrofe naturale, che talvolta provoca una rigenerazione'.
'È una frattura nel tempo, uno iato. In ambito cinematografico si parlerebbe di errore di continuità o di ellissi. In un contesto fatto di rotture e catastrofi, le azioni non sono lineari né cronologiche. Unconformities è il tentativo di un resoconto poetico della storia che sta sotto i nostri piedi attraverso un materiale che evoca fratture nel tempo, ma anche l’impatto duraturo delle azioni umane sul pianeta’.
Si richiamano, come già detto, alle intuizioni di Latour, e perciò stanno bene attenti a non lasciare solo l’amaro intollerabile di questo racconto di realtà. Spiegano bene che ‘in quest’epoca tragica, Bruno Latour ha saputo far emergere un entusiasmo, persino uno spirito combattivo, nell’affrontare le catastrofi. Parlava di un’apocalisse esaltante. In un certo senso, è proprio ciò che anche noi ci troviamo ad affrontare’.
Di sicuro, come suggerisce una vicina, spettatrice competente e bulimica ormai pentita, l’apocalisse a cui introduce ‘La vertigineuse histoire d’Orthosia’ è in primo luogo catastrofica per il teatro e lo spettacolo che purtroppo siamo abituati a vedere, la cui insopportabile e sciatta inutilità si appalesano subito al confronto.
Tocca di ripetere quanto diceva prima di entrare un altro giovane appassionato del ramo, che è anche attore per diletto: ‘questa settimana sono già venuto in Triennale a vedere ‘A Visual Diary’ di Fabio Cherstich, bisogna dare atto che, in un panorama teatrale così polveroso, i programmi di Umberto Angelini si staccano per novità e livello’.
Già, il direttore neo-Chevalier des Arts, quando alza davvero l’asticella delle proposte, si guadagna ogni volta da capo la stima e la considerazione che merita: gli basta un tocco così per farsi perdonare dagli arci-criticoni snob, in un pugno di ore, persino certe impegnative furbate, come gli ingaggi plueriennali agli osannati Romeo Castellucci o Marcos Morau.

Riflettendo nei giorni seguenti su questo spicchio meraviglioso di pensiero e di civiltà relativa che ci è stato offerto dal duo libanese alle prese con ‘l’esaltante apocalisse’ di Latour, è facile sentir aleggiare ancora un’altra intuizione di Benjamin che, muovendo dall’opera di Nicolaj Leskov, metteva a fuoco la sapienza narrativa dei giusti.
Sia chiaro, il caso dei nostri due libanesi non ha niente a che vedere con il mondo degli angeli sbandati, dei pecoroni e dei mentecatti nella Russia zarista, ma in fondo potrebbe esserne la versione intellettuale post-moderna, di una marginalità capace di generare sapienza originale, che capita di riconoscere anche in altri artisti erranti mediorientali (per citare un solo esempio già presentato, l'esule francese di origine palestinesi Taysir Batniji).
Il giusto, nella sua apparente strampalatezza, è l’unico che può persino riportarci magicamente come dinanzi allo stato originario delle cose.
‘Il giusto’, recita in conclusione Benjamin nel saggio su Leskov, ‘è il portavoce delle creature ed insieme la sua più alta incarnazione. E così vediamo che la sua essenza immutabile è quella di un essere ‘favolosamente scampato alla follia del mondo’ e che, proprio mercé questa sua caratteristica, è in grado, attraverso i suoi racconti, di portare un annuncio di salvezza, di apocatastasi’.
Con tante scuse per i paroloni, di rimando in rimando, dall’analisi su Benjamin e le pietre dell’apocalisse di Raffaele K. Salinari, si arriva a quel ‘lapis philosophorum’ dell’Alessandrite, il pezzo di vetriolo citato nel racconto di Leskov e all’acronimo V.I.T.R.I.O.L., comparso dal 1613 anche in alchimia, nel Basilius Valentinus. Sta per l’invito iniziatico ‘Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem’, cioè Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta.
E che Hadjithomas e Joreige possano continuare questi loro scavi per condividerne ancora il risultato con l’emozione artistica che sanno suscitare.